Avete mai avuto l’impressione che il vostro lavoro non serva a un cazzo e di essere pagati per delle attività completamente inutili? Avete mai provato vergogna segreta (cioè: senza il coraggio di dirlo a qualcuno) per il fatto di guadagnare soldi in cambio di attività senza senso, pur ricoprendo un ruolo socialmente riconosciuto, perfettamente legale e tutelato, nonché ben visto da tutti? Se il vostro problema non è la precarietà economica, lo stress fisico da lavoro massacrante, la classica difficoltà di “arrivare all’ultima settimana del mese”, allora dovreste leggere il libro Bullshit Jobs di David Graeber, professore di antropologia alla London School of Economics.
Ci sono pochi libri che posso dire mi abbiano cambiato la vita. Tra questi, il libro di Graeber senza alcun dubbio. Infatti mi ha finalmente donato (alla modica somma di una quindicina di euro) una chiave di lettura per capire che cosa è (diventato) il mondo del lavoro pubblico e privato, aziendale, profit e no-profit, accademico, scolastico, sanitario, musicale, artistico, cinematografico…etc. Una diagnosi, quella di Graeber, che mi ha spiegato quello che avvertivo, ma non riuscivo a dire, o non avevo il coraggio di dire (se non alla mia terapeuta). Una diagnosi che mi ha fatto capire che non sono solo, ma – stando alle stime – siamo parecchi milioni al mondo.
Il presupposto da cui parte la teoria di Graeber è chiarissimo e vale la pena lasciar parlare l’autore:
“Nel 1930, John Maynard Keynes aveva previsto che, entro la fine del secolo, lo sviluppo della tecnologia sarebbe stato tale da consentire a paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di avere una settimana lavorativa di quindici ore. Ci sono tutti i motivi per credere che avesse ragione. Dal punto di vista tecnologico, le condizioni esistono già. Ciononostante non è accaduto. Al contrario, la tecnologia è servita semmai per trovare il modo di farci lavorare tutti di più. Per riuscirci si sono dovuti creare impieghi che di fatto sono inutili. Ampi strati della popolazione, in particolare in Europa e nel Nord America, passano l’intera vita lavorativa a svolgere compiti che in cuor loro ritengono non andrebbero affatto svolti. Il danno morale e spirituale che ne deriva è grave. E’ una cicatrice che segna la nostra anima collettiva, anche se praticamente nessuno ne parla.” (Graeber, “Bullshit Job”, p.9)
Oggi, 2019, dovremmo dunque lavorare in media 12-15 ore a settimana. Nella realtà, si lavora circa 40 ore settimanali, spesso molto di più. Il bello è che si cominciano a salutare casi di contratti a 30 ore settimanali (es. in Svezia) come se fossero esperimenti rivoluzionari, quando invece anche le 30 ore sono una esagerazione. Infatti, – fermo restando le 12-15 ore settimanali – tutto il resto, se si ha l’onestà di ammetterlo a se stessi, è tempo speso a fare attività che, nel migliore dei casi, sono completamente inutili; nel peggiore dei casi sono dannose alla società.
Certi lavori – scrive Graeber – “sono a tal punto inutili che nessuno si accorge se scompare chi se ne occupa” (p.23). L’autore riporta come esempio introduttivo una notizia a dir poco curiosa (tratta da un caso del settore pubblico, ma l’autore correttamente mostrerà in tutto il libro come il fenomeno sia esteso anche al settore privato). Ancor più curioso è scoprire, poi, che di questi casi è pieno il mondo (ripeto: non solo pubblico, ma anche nelle aziende private!):
“Jewish Times” del 26 febbraio 2016:
Impiegato statale non si presenta al lavoro per sei anni per studiare Spinoza. I media spagnoli informano che un dipendente pubblico spagnolo, che ha riscosso uno stipendio per almeno sei anni senza andare al lavoro, ha impiegato il suo tempo per diventare un esperto delle opere del filosofo ebreo Baruch Spinoza. […] La sua assenza è stata notata la prima volta nel 2010, quando [il dipendente – ingegnere del servizio idrico fin dal 1996] avrebbe dovuto ricevere una medaglia per il suo lungo servizio. […] L’ingegnere ha spiegato di aver doverosamente assolto per molti anni il compito di monitorare l’impianto di depurazione dell’acqua della città, poi a un certo punto l’ente per il servizio idrico era passato sotto il controllo di superiori che lo detestavano per le sue idee socialiste e si rifiutavano di attribuirgli una qualsiasi responsabilità. […]invece di continuare a stare lì tutto il giorno fingendo di essere occupato, decise di far credere alla società dell’acqua potabile di dipendere dal controllo del comune e al comune di dipendere da quello della società dell’acqua potabile; si sarebbe fatto vivo solo nell’eventualità di qualche problema, altrimenti sarebbe stato a casa a fare qualcosa di più proficuo per la sua vita (cfr. pp.23-24).
Graeber propone anche una definizione di bullshit job: per lavoro senza senso si intende un’occupazione retribuita che è così totalmente inutile, superflua o dannosa che nemmeno chi la svolge può giustificarne l’esistenza, anche se si sente obbligato a far finta che non sia così”. (p.31)
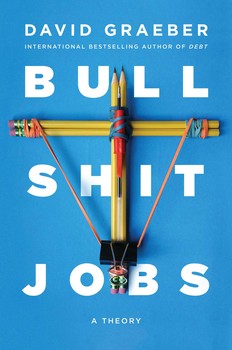
Nel libro vengono proposte cinque categorie di bullshit job, espressione traducibile con : “lavoro del cazzo”, “lavoro del cavolo”, “lavoro inutile”, “lavoro senza senso”, “lavoro assurdo”:
- tirapiedi (flunkies) “esistono solamente o principalmente per far sembrare o sentire importante qualcun altro” sono i “servitori feudali”, i “galoppini”, i “porta borse” etc.;
- sgherri (goons) persone il cui lavoro presenta una componente di aggressività, di solito metaforica o simbolica, non necessariamente fisica, ma che – ecco il punto – esistono solo perché altri le impiegano. Es. legali d’azienda, guru del marketing etc.;
- ricucitori (duct tapers) sono dipendenti i cui lavori esistono solo per un difetto o una mancanza nell’organizzazione; sono lì per risolvere un problema che non dovrebbe esistere.; Es. programmatori software;
- barracaselle (box tickers) esistono solo o principalmente per consentire a una organizzazione di affermare che sta facendo qualcosa che in realtà non sta facendo (es. Compliance Manager, HR manager etc.);
- supervisori (taskmaster) il cui ruolo consiste unicamente nell’assegnazione di lavoro ad altri
(cfr. pp. 52 e sgg.)
Graeber correttamente distingue i bullshit job, o lavori senza senso del tipo appena visto, dai lavori “di merda”, cioè quelli fisicamente massacranti, sottopagati, precari, schiavizzanti, etc. che però sono quei lavori estremamente utili, necessari al benessere delle persone e dell’ambiente (incluso il benessere delle persone che hanno un bullshit job, ad esempio chi pulisce i loro uffici aziendali!) e che portano autentico valore alla società. Solo che a fare quei lavori si viene pagati poco e male, secondo un principio più o meno implicito per cui tanto più un lavoro è importante – per davvero! – tanto meno esso sarà riconosciuto socialmente ed economicamente; tanto meno un lavoro è sensato e utile alla collettività, tanto più sarà considerato economicamente e socialmente. Scrive l’autore:
I lavori di merda in genere sono quelli degli operai, vengono pagati all’ora, mentre quelli senza senso sono di solito quelli dei colletti bianchi e sono stipendiati. Coloro che svolgono lavori di merda in genere vengono oltraggiati; non solo lavorano sodo ma proprio per questo sono tenuti in bassa considerazione. Almeno, però, sanno di fare qualcosa di utile. Coloro che svolgono lavori senza senso godono spesso di onore e prestigio; sono rispettati in quanto professionisti, ben pagati e trattati come individui di successo, ossia quel genere di persone che possono giustamente essere orgogliose di quello che fanno. Tuttavia, nel loro intimo, sanno di non aver raggiunto alcun risultato; capiscono di non aver fatto nulla per meritarsi i giocattoli consumistici con cui riempiono le loro vite; sentono che il tutto si fonda su una menzogna, e infatti è così. (p.37)
Certo, anche i bullshit job sono – in senso lato – lavori di merda, ma – per così dire – sono come quelle merde che se le pesti ti portano fortuna, una “merda fortunata”, perché, al prezzo dell’insensatezza, assurdità, frustrazione psicologica, spirituale ed esistenziale, si ottiene sicurezza economica, un ottimo stipendio, privilegi sociali, le ferie a Ibiza e la playstation. Gli altri sono lavori di merda in senso stretto, perché, al prezzo di fatica, sudore, umiliazione, si ottiene il minimo per sopravvivere.
Torniamo a concentrarci sui nostri amati bullshit job da colletti bianchi e ci chiediamo: cosa fa la maggior parte delle persone che ha un lavoro del genere per riuscire a passare il tempo oltre alle fatidiche 12-15 ore e riempire così le 40 ore settimanali? Ecco alcune opzioni emblematiche (si noti che una non esclude l’altra) – che deduco in parte dal libro, in parte dalle esperienze professionali che mi circondano:
1) Cazzeggiare sui social media, immischiandosi in argomenti che nulla hanno a che fare col proprio “lavoro”;
2) Cazzeggiare sui social media “professionali” come LinkedIn, mostrando quanto figo sia il suo lavoro e utilizzando una quantità di hashtag #lovemyjob# direttamente proporzionale a quanto cagare gli fa in realtà il suo lavoro.
3) Cazzeggiare su siti di “riferimento” (siti influencer!!!) per il proprio “ruolo professionale”, dove di fatto viene ripetuto sempre lo stesso mantra, che può essere generato a caso da un vocabolario di una decina di parole (come ad esempio: leader, customer-centric, strategic, optimization, streamline, digital transformation, innovation, collaboration) (cfr. il bullshit generator, bellissimo esempio segnalato nel libro).
4) Chattare con colleghi, amici e amanti, oppure con bimbiminkia conosciuti su un qualche Tinder-like-digital-platform.
5) Fingere una telefonata di lavoro (una “call”) e invece chiamare il piastrellista per la casa nuova, comprata con il proprio stipendio da bullshit job.
6) Telefonare per lavoro (ma per davvero!), fissare riunioni, fare “call su skype for business”, seguire webinar sulla digital transformation, draftare presentazioni in powerpoint sulla task force dedicata alla growth revenue del proprio team, con proposte embeddate per un enhancement del proprio department, in ottica olistica end-to-end con l’intera supply chain, finance e operativa, across the entire pipeline. Qui si tratta, insomma, di autoconvincersi che si sta lavorando e si è utili, mentre si sta semplicemente portando in giro per la stanza la stessa merda fortunata che si è pestata il giorno in cui si è ottenuto quel ruolo “professionale”. Qui si lavora credendoci per davvero (e non per finta) tutto il tempo, dalle 9 alle 18, o addirittura fino alle 21 se a casa ti aspetta una moglie o un marito che ti sta sui coglioni.
Se non si vuole rientrare in queste pratiche, o comunque se si vuole limitare il più possibile di intrappolarsi in queste situazioni, ci si dovrebbe porre la classica domanda Leniniana: “Che fare?”. Tenete presente che Graeber stesso non ha e non vorrebbe dare una risposta. Quel poco che suggerisce è da prendere con le pinze, per sua stessa ammissione, in quanto potrebbe generare ulteriore burocrazia (il concime dei bullshit job, letame freschissimo. Non a caso l’autore ha anche scritto un ottimo libro dal titolo The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy). Vorrei quindi restringere la domanda: “Che fare?” al singolo individuo, e non alle scelte che i governi o le aziende o i movimenti politici, o i partiti, o gli imprenditori illuminati dovrebbero prendere.
Supponiamo che io abbia un bullshit job, dall’altisonante titolo di “Senior Digital Transformation Enabler” e che il mio profilo LinkedIn dica che “aiuto le aziende a digitalizzare le strategie lungo tutta la supply chain, in ottica di innovazione 4.0”. (Se pensate che questa descrizione di lavoro sia una presa in giro, fatevi un giretto su LinkedIn; se pensate che questa descrizione identifichi un insieme di attività sensate e utili, fatevi un giretto in una qualsiasi azienda di almeno 50 persone).
Con il mio bel lavoro del cazzo, che mi occupa circa 15 ore a settimana da ricucitore (v. sopra), con alcuni tratti da sgherro (v. sopra), devo riempire in qualche modo il resto del tempo, circa 25 ore settimanali. Supponiamo che voglia fare qualcosa di costruttivo per me e – se sono particolarmente generoso – per il mondo. Di solito si hanno almeno queste opzioni che di fatto sono opzioni praticate da persone reali, come mostrano i numerosi esempi- divertenti e al contempo drammatici – presentati dall’autore del libro (si noti che una opzione non esclude l’altra):
- Studiare e imparare cose belle. Una delle poche cose che rendono la vita degna di essere vissuta è imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, applicarsi, esercitarsi, vedere il miglioramento giorno per giorno, e creare qualcosa di proprio grazie a quanto appreso e…nel migliore dei casi…fare qualcosa che lasci il mondo leggermente migliore di come lo si è trovato. Esattamente l’opposto, quindi, di quello che si fa quando si è incastrati in un bullshit job (che per definizione è inutile, non serve a un cazzo, non presuppone di sapere praticamente una sega – anzi, devi dimenticare quel poco che sapevi se non vuoi disturbare troppo; e lascia il mondo identico a prima o forse peggio). Certo, bisognerà ingegnarsi per non essere “scoperti” (i datori di lavoro quanto sanno di tutto questo? Ne parlo tra poco) e trovare o avere già una passione “logisticamente” gestibile con un computer, una connessione internet e un paio di cuffie.
- Ottimizzare policy di clean-desk. Sembra una bullshit activity, ma in realtà – se la parafrasiamo in linguaggio naturale – diventa: “pulire meglio la tua scrivania piena di schifo, ivi compresa la tastiera del computer che ha ancora le croste da naso di due anni fa incastrate tra le lettere C,V,B,N e M”. Uno dei rarissimi momenti di lavoro reale in azienda. Utile e sano, peccato che si potrà fare, sì e no, un’ora a settimana al massimo.
- Licenziarsi e lavorare freelance, con tutto ciò che ne consegue, nel bene e nel male.
I datori di lavoro lo sanno? Credo che ci siano tre ipotesi principali:
- Non lo sanno e pensano che – al massimo – un dipendente perda circa il 20 o 30% del tempo in cazzeggio fisiologico (caffé, pipì, popò, telefonata alla morosa);
- Lo sanno, lo ammettono a loro stessi, ma per loro l’importante è che il dipendente stia al suo posto e faccia finta (sicché sarà tollerato persino il cazzeggio totale, basta che avvenga in segreto, al proprio “smart desk”);
- Lo sanno, ma non lo ammettono a loro stessi, perché vogliono credere che i propri dipendenti lavorino quasi tutto il tempo (questo potrebbe essere un esempio interessante del cosiddetto paradosso di Moore)
Ovviamente, nessun datore di lavoro che lo sa e lo ammette a se stesso andrà a dirlo al proprio dipendente…o meglio, se succede, allora si tratta di un discorsetto propedeutico al licenziamento oppure l’azienda ha fallito (e sei comunque licenziato). Un po’ come quei matrimoni basati sulla finzione: non appena uno dei due dice la verità (“Non ti amo”, “Non ti ho mai amato”, “Preferisco il cetriolo alla patata”, “Preferisco la verza alla zucchina”, etc.), il matrimonio si sfascia (a meno di non dimenticare tutto e ricominciare la finzione).
Ma – si chiede Graeber – com’è possibile che una macchina com’è quella capitalista e neocapitalista, perfettamente tarata per seguire come unico driver il profitto, generi, tolleri e perpetui così tanti posti di lavoro inutili, che di fatto sono solo un costo per l’organizzazione? Questa è una delle principali obiezioni che sono state mosse alla teoria di Graeber e a cui l’autore ha risposto in modo più che soddisfacente, a mio avviso. Ad ogni modo credo che chiunque abbia un po’ di onestà intellettuale e non sia del tutto bruciato nel cervello, dopo aver lavorato diversi anni come colletto bianco accumuli una quantità di conferme pratiche della teoria di Graeber. Sicché l’onere della prova va agli avversari della teoria di Graeber e non alla sua teoria! Provino pure, insomma, a mostrare con casi concreti che i lavori dei colletti bianchi sono utili…
Il libro esamina in modo approfondito anche i possibili motivi per cui le politiche di tutti o quasi tutti i governi abbiano consolidato e promosso questa situazione (basta ascoltare qualsiasi campagna elettorale e al primo punto ci sarà la creazione di posti di lavoro, anche da chi propone un reddito di cittadinanza). Una delle cause individuate da Graeber è quella del controllo sociale: tenendo milioni di persone inchiodati a una scrivania si evita che possano progredire come esseri umani: una persona che ama le cose belle sarebbe “pericolosa” per lo status quo, dove vige la dittatura della mediocrità. E siccome per imparare ad amare le cose belle ci vuole tempo, è meglio far collassare il tempo delle persone sul tempo di un bullshit job (o – dall’altra parte della barricata – sul tempo di un lavoro di merda). Graeber, inoltre, propone delle correlazioni interessanti con morale religiosa, dinamiche di sessualità sado-maso, “neofeudalesimo manageriale”, ripresa dei valori della borghesia, etc. Lascio al lettore l’approfondimento.
“E le startup agili, smart e flessibili, dove le mettiamo?” – direte voi. E le aziende “illuminate”, smart, il cui “CEO” è un profeta, Figlio della Luce, la cui vita quotidiana (abbigliamento incluso) diventa un modello da seguire per avere la Gioia Eterna? Le aziende dove il CEO siede alla destra del Founder ed è stato riconosciuto come 87esima reincarnazione del Dalai Lama? Quelle dove l’HR Manager in realtà è un Buddha o almeno un Bodhisattva? Quei digital incubator dove non c’è confine tra l’orario di lavoro e la vita personale perché è sempre tutto un meraviglioso pensiero creativo in atto – e altro che banali orari di lavoro? Quegli uffici dove si vive di pura immaginazione e si contempla il volto del Dio Sole, adagiati su una fracchia, tra una partita a ping pong e uno workshop sul cambiamento climatico? Allora? Anche su questo Graeber ha qualcosa da dire, in una noticina nascosta nel libro: lascio al lettore l’onere di trovarla e – si spera – di capirla.
In conclusione, se leggerete questo libro, avrete uno strumento “diagnostico” potentissimo per comprendere quello che sta succedendo (o meglio: è già successo) nel mondo del lavoro. Dopodiché, potrete far finta di niente, o addirittura prendervela con l’autore. Probabilmente molti tra i “colletti bianchi” e moltissimi tra gli imprenditori, politici ed economisti sosterranno che l’autore si sbagli, esageri, o persino sia in malafede. D’altro canto, come diceva Leopardi:
“Sogliono essere odiatissimi i buoni e i generosi perché ordinariamente sono sinceri, e chiamano le cose coi loro nomi. Colpa non perdonata dal genere umano, il quale non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina”.
[aawp box=”881167266X”]


